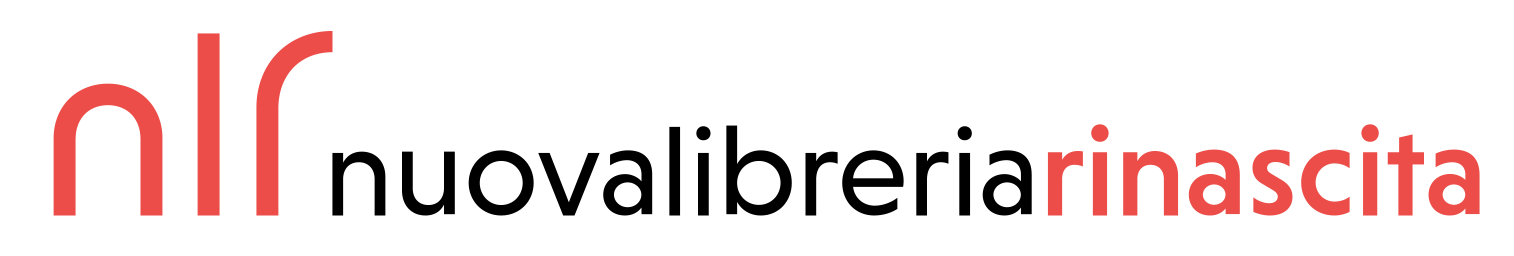Sul tetto c’è Mendelsshon Jiří Weil, Einaudi 2023 (pp. 300, euro 20)


L’umorismo corrosivo e sornione di Hrabal, e prima ancora di Hašek, connazionali dell’autore e da lui non distanti per età, fa capolino sin dall’inizio in un romanzo che non perde occasione di evidenziare come, fra rapporti di servizio, verbali e registri di confisca, è la “soluzione finale” che si prepara, e gli uffici, silenziosi ed efficienti, sono il necessario corrispettivo dei campi di sterminio. C’è chi se la cava e chi no, nella Praga occupata dai nazisti, ma proprio il disincanto dell’autore, e il suo apparente distacco, consentono di denunciare la bestiale insensatezza del loro potere.
Già la prima pagina spiega il titolo: il Mendelssohn citato è proprio Felix, il musicista, o meglio, la statua che lo raffigura, fra le altre che ornano il tetto della “Casa tedesca delle arti”, già sede del Parlamento cecoslovacco. Si tratta di “una statua ebrea”, come il nome del musicista rende evidente, secondo le autorità della Gestapo, e va quindi “scaraventata giù dalla balaustra”. Perché, si sa, “le statue sono sempre state le guardiane fedeli e il baluardo di questa città tedesca” – quale gli occupanti pretendono sia Praga – e dunque occorre che anche fra di esse si faccia pulizia: ordine di Heydrich, il responsabile supremo della “soluzione della questione ebraica”, operante nella capitale ceca.
Ma non è come dirlo: occorre riconoscerla prima di tutto, la statua di Mendelssohn, in mezzo a quelle di altri musicisti – ariani, ovviamente. Né i due inservienti spediti lassù né l’impiegato comunale e “aspirante SS” incaricato dell’operazione sanno come fare: non ci sono scritte e le statue sono molto simili fra loro. Ma ecco l’idea: “Quella col naso più grosso, quello è l’ebreo”.
L’umorismo corrosivo e sornione di Hrabal, e prima ancora di Hašek, connazionali dell’autore e da lui non distanti per età, fa capolino sin da questo inizio: la statua di Wagner, il musicista prediletto dal Terzo Reich, sembra vantare il naso più imponente. Il capo squadra evita per un pelo che i suoi sottoposti commettano lo scempio. Non resta che interpellare un “dotto ebreo”, a questo punto, e dunque avviarne la ricerca per poi sfruttarne le conoscenze: la trafila burocratica, la pedanteria impiegatizia. le piccole e grandi soverchierie, le violenze gratuite, la corruzione che pervade i diversi gradi dell’apparato senza risparmiarne neanche i più infimi offrono materia a chi ne narra con ironia implacabile i risvolti e ne rivela al contempo la logica mortifera. “Dentro centinaia di documenti, dentro gli schedari”, infatti, sta in agguato la morte: fra rapporti di servizio, verbali e registri di confisca è la “soluzione finale” che si prepara, e gli uffici, silenziosi ed efficienti – almeno formalmente –, sono il necessario corrispettivo dei campi di sterminio.
Neanche il colto dottor Rabinovič – direttore suo malgrado del museo di oggetti di culto ebraici voluto dal Reich, “il museo di un popolo estinto” – riesce però a individuare la statua incriminata: “è un talmudista, che non ha la benché minima idea di una cosa laica com’è la musica”, e infatti si limita, una volta portato anche lui su quel tetto, a informare che Mendelssohn – le cui fattezze gli erano per altro del tutto sconosciute – era stato battezzato da piccolo e non era ebreo dunque.
È un altro impiegato, superiore diretto del primo – nel frattempo spedito al fronte per punizione – a individuare la statua, grazie alla moglie che ricorre a certi conoscenti musicisti. Eccoli di nuovo sul tetto dunque, i due inservienti, che fanno la pensata di rimuovere sì il povero Mendelssohn, ma di adagiarlo in modo che il danno si limiti a un mano e possa essere ricollocata, un domani, quando i nazisti se ne saranno andati.
Le peripezie della statua del musicista dal nome ebreo costituiscono solo uno, il più grottesco, dei filoni della storia, la quale si articola in tragiche vicende di sofferenza mettendo in scena numerosi altri personaggi.
Un filo percorre comunque l’intera narrazione e lo si può individuare, come anticipato dalla nota dell’editore, nella filosofia della storia dell’autore. “Se Vasilij Grossman è il cantore della ‘bontà’, immotivata e priva di senso eppure a suo modo salvifica per l’uomo – come si era evidenziato anche in queste note all’inizio del novembre 2022 –, a Jiří Weil non saremo debitori di nessuna rassicurazione. Unica artefice dei nostri destini terreni è la Fortuna, entità assai più cieca della Giustizia”: “nessuna ratio meritocratica, o morale. C’è chi se la cava e chi no, sempre per caso”. Il che non significa che non siano distinguibili vittime e carnefici e rintracciabili responsabilità e colpe, sadismi e assassini, che proprio il disincanto dell’autore, e il suo apparente distacco, consentono di denunciare nella loro bestiale insensatezza.
Brescia, 27 marzo 2024
Carlo Simoni
www.secondorizzonte.it