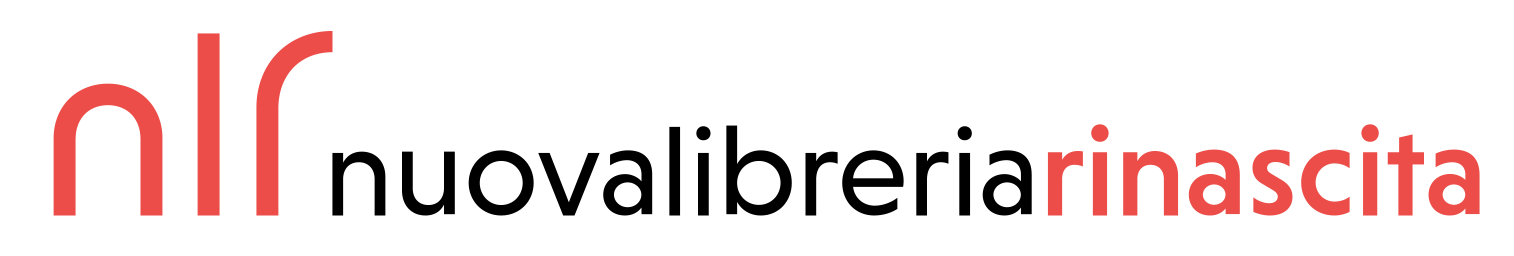L’Io che racconta e l’Io di cui si racconta Carlo Simoni, Se viene qualcuno, Castelvecchi 2021 (pp. 400, euro 25)


Il nostro Carlo Simoni ama leggere, lo avrete capito dalle recensioni che cura anche per noi ogni settimana, e ama scrivere. Da pochi giorni è in libreria «Se viene qualcuno» (Castelvecchi, 400 pagine, 25 euro).
“Se viene qualcuno” è l’intercalare – si legge nella quarta di copertina – che accompagna i discorsi di Gina, la madre del protagonista, per tutta la vita, e che negli anni perderà via via i colori di una speranza vaga per assumere quelli di una minaccia incombente. Il taglio autobiografico di questo romanzo fatto di racconti non impedisce all’autore di dar conto dell’esemplarità della vicenda della sua famiglia in quella più generale del dopoguerra e del secondo Novecento nel nostro Paese, muovendosi non sul terreno della ricostruzione storica ma su quello dell’evocazione narrativa, dell’immedesimazione – anche sul piano linguistico – con il bambino e poi il ragazzo di un tempo.
A emergere sono momenti cruciali che la narrazione privilegia in forza di una necessità dettata dalla percezione del carattere essenziale e per nulla logorato di alcuni ricordi, dalla certezza del ruolo da essi giocato nel determinare passaggi nodali, qualificanti la singolarità di una formazione. Il tutto, giocato sempre nella consapevolezza del carattere indistinto e mutevole della relazione fra l’Io che racconta e l’Io di cui si racconta.
Quelli che seguono sono alcuni brani tratti da Genealogie, mitologie, la nota che compare nelle ultime pagine del libro
Erano passate poche settimane dalla morte di mio padre quando, nel 1985, scrissi l’inizio, solo qualche pagina, del racconto della sua malattia e della sua fine.
Ci sono voluti altri vent’anni perché riprendessi quell’abbozzo, scrivessi La morte di Giuseppe e di seguito, come fosse caduto un impedimento, alcune storie della mia infanzia, a partire da La stella: potevo parlare di me, partendo da quello che mi era rimasto nella memoria come un momento di iniziazione, solo dopo aver raccontato di lui, della sua vita, dell’uomo che ai miei occhi era stato.
Soltanto un breve racconto avevo scritto prima, nella seconda metà degli anni Novanta, Fraternità. L’avevo regalato a mio fratello per il suo sessantesimo compleanno. Ma si era trattato di un episodio isolato. Così avevo creduto, quantomeno.
Il desiderio di scrivere tuttavia, di scrivere per raccontare – non più per render conto, spiegare, persuadere… – era ormai affiorato, non era nuovo ma occorreva che lo riconoscessi, che sentissi di poterne fare qualcosa. Ed era appunto dalla storia di mio padre che dovevo incominciare. Senza pensare che la scrittura mi avrebbe liberato dalla sensazione che i conti con lui erano e sarebbero rimasti aperti. Sapendo bene, anzi, che non si trattava di tentare di chiuderli ricostruendo ragioni, elaborando spiegazioni, ma di riconoscere che proprio questo era il modo in cui mio padre avrebbe continuato a essere presente nella mia vita. Di riconoscerlo nei fatti, secondo le mie capacità, seguendo la mia inclinazione: scrivendo, appunto, raccontando di lui, di me, di noi. Della mia famiglia.
Il titolo di quella che allora pensavo avrebbe costituito solo una raccolta di quattro o cinque racconti si era imposto fin dal momento in cui sulla scena, accanto a quella di Giuseppe, era comparsa la figura di mia madre, e con lei quel suo intercalare, Se viene qualcuno, unica cellula di un lessico familiare che ha lasciato traccia nella mia memoria degli anni dell’infanzia ma è poi andato disperso, negli anni Sessanta e nei cambiamenti che da quel momento sono intervenuti, come le fotografie dell’album fino allora conservato.
Se viene qualcuno, parole che ho sentito pronunciare da mia madre per tutta la vita, risuonare nelle diverse case che abbiamo abitato, perdendo via via i colori di una premura vaga, venata di speranza forse, per assumere quelli di una minaccia indistinta. Solo dopo, però, che i ricordi dell’infanzia e dell’adolescenza, e di qualche momento della mia prima giovinezza, si erano sedimentati in una ventina di racconti, è venuto il momento di creare uno spazio del quale mia madre, da figura aleggiante nella gran parte delle vicende evocate, si facesse protagonista.
Corrispettivo del primo si può quindi considerare il quinto capitolo. Momenti di sintesi, pur nell’andirivieni della memoria che li contraddistingue, La morte di Giuseppe e Mancare la vita svolgono un ruolo portante, come i due pilastri di un ponte sospeso sul quale hanno potuto disporsi in successione le altre storie.
Sono nate da un’ultima rilettura queste considerazioni, insieme a quelle che seguono: il bilancio di un’esperienza conclusa, dunque, anche se alimentato dalle riflessioni, dalle incertezze, dalle risoluzioni sempre provvisorie emerse nel corso della scrittura. Non è un progetto ad averla guidata, infatti, ma il desiderio di comprendere. Un desiderio consapevole del proprio orientamento, meno del proprio oggetto che – lo avrei appreso in seguito, per approssimazioni successive – solo la scrittura poteva rivelare, rintracciando nella storia della mia famiglia il segno lasciatovi dai tempi precedenti e immediatamente successivi alla mia nascita, da un lato, e, dall’altro, i momenti cruciali del formarsi della mia personalità, del mio carattere. I tratti salienti di quello che sarei diventato. Di quello che sono.
Un percorso a ritroso, dunque, era quello che mi si imponeva. Un’indagine genealogica da giocarsi tuttavia non sul terreno dello storico, da me a lungo praticato, ma su quello del narratore, possibile dunque solo attraverso una presa di distanza – senza la quale la memoria non si fa scrittura – che non poteva identificarsi nel distacco di chi indaga il passato sulla base di documenti certi (…).
Non il generico intento di dare uno sfondo alla storia della famiglia Savona, ma la percezione e la conseguente volontà di dar conto dell’esemplarità della sua vicenda in quella più generale del dopoguerra e del secondo Novecento nel nostro paese esigeva che, a parte i nomi, nessun’altra circostanza dovesse essere cambiata. E le voci stesse dei personaggi potessero essere restituite fedelmente. A partire da quella del bambino, e poi del ragazzo che sono stato, in modo tale che la frammentazione, la discontinuità della narrazione trovassero riscontro in una modulazione via via diversa della voce narrante, adulta nei due capitoli che si sono definiti portanti, espressione delle età precedenti negli altri.
Falsi ricordi, ricordi di copertura, illusione di poter rinvenire archetipi, tendenza a congegnare mitizzazioni, e rimitizzazioni, occulti desideri di revisione di ciò che è stato, nello spirito di bandire equivoci annosi, di guadagnare un chiarimento definitivo se non una sorta di rivalsa: sono di varia natura le considerazioni critiche, a proposito dello scrivere di sé, che rendono ineludibile il sospetto che ogni sforzo di risalire al proprio passato, ogni genealogia, finisca per risolversi in una mitologia, e che ogni intenzione di rivisitare la propria storia finisca con il risultarne se non una falsificazione interessata, in quanto viziata da un narcisismo di fondo, un involontario quanto inconsapevole travisamento di fatto.
Come non intravedere una tentazione mitologizzante già nel fatto di credere alla sostanziale continuità di un Io passato attraverso tempi fra loro distanti ed esperienze disparate? Un Io che, oltre tutto, ha ereditato mitologie che appartenevano ad altri, ai propri genitori come a tanti italiani loro coetanei.
(…)
Sono state considerazioni simili, arrivate soltanto dopo aver scritto le parole che chiudono l’ultimo capitolo, a darmi conferma definitiva che il romanzo era davvero giunto alla sua conclusione.
La sua, non quella della storia da cui si è originato. La mia storia.
“Si racconta bene – constatava Italo Calvino – di ciò che si è lasciato alle nostre spalle, che rappresenta qualcosa di concluso (e poi si scopre che non è concluso affatto)”.
Brescia, 10 dicembre 2021
Carlo Simoni
www.secondorizzonte.it