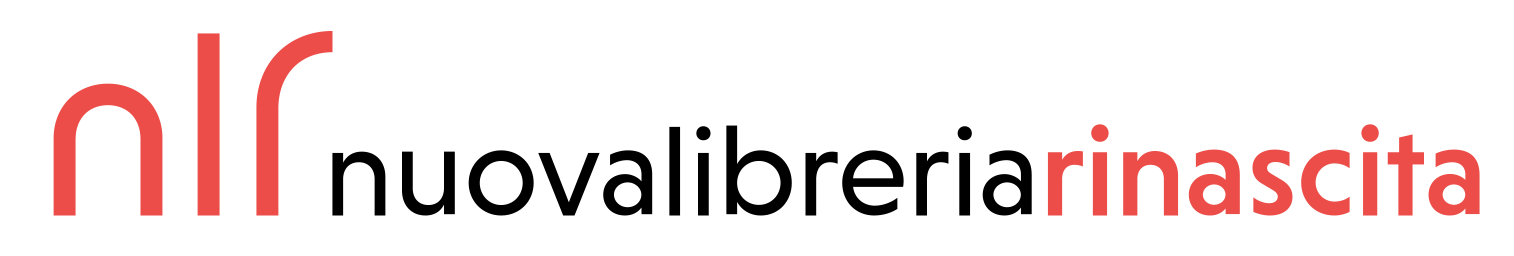Andy Warhol? Ora ve la racconto io come è andata Intervista a Nadia Busato, autrice di Factory Girl (Sem)
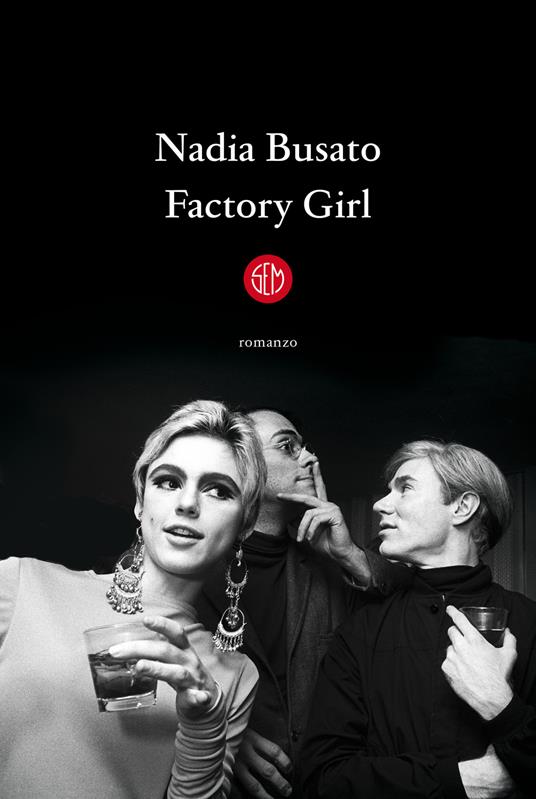

Silvia ha intervistato Nadia Busato, da pochi giorni in libreria con il suo \’Factory Girl\’ (Sem)
Edie Sedgwick fu una delle diverse muse di Warhol. Perché hai deciso di raccontare proprio la sua storia?
I motivi sono essenzialmente due. Il primo è che, durante le ricerche per \”Non sarò mai la brava moglie di nessuno\” ho avuto la fortuna di poter intervistare due volte John Giorno, poeta e artista, compagno di Warhol nel periodo in cui trova l\’immagine di Evelyn McHale a la riproduce nei lavori del ciclo \”Death and disasters\”. Warhol è stato il primo artista a consacrare l\’iconico scatto di Robert Wiles e a consegnarlo al mondo dell\’arte contemporanea. Lo ha fatto anche perché la sua adorazione per le icone di bellezza femminile avevano come valori nobilitanti l\’estrema fragilità e la spinta all\’autodistruzione: due valori su cui, mi azzardo a generalizzare, si fondava la cosmogonia hollywoodiana delle dive come Marylin Monroe. Edie come Evelyn vive la sua vita lottando per il suo riscatto, muore tragicamente e viene venerata solo in virtù della sua fotogenia. Un tradimento in vita e dopo la morte che appartiene a molte donne, le cui rivendicazioni vengono annichilite e apertamente vilipese. Parlare di Edie Sedgwick e delle superstars della Factory mi ha permesso di tornare a New York, vent\’anni dopo la fine della seconda guerra mondiale, nel luogo più rivoluzionare della controcultura, per leggere un altro pezzo di storia dal punto di vista delle ragazze.
Ci sono più fili che legano Edie Sedgwick a Evelyn McHale, la cui storia ha ispirato il tuo precedente libro Non sarò mai la brava moglie di nessuno e uno di questi è Andy Warhol: cosa rappresenta per te il mondo di Warhol?
Esattamente come Ultra Violet, che lo dice e lo scrive più volte, non riesco a parlare di Andy Warhol al passato perché, di fatto, non se n\’è mai andato. Le opere legate al suo nome continuano ad essere vendute a cifre folli (nonostante non le realizzasse lui), è protagonista di una serie ipercelebrativa su Netflix, è il capostipite di artisti che sono prima di tutto delle star, come Damien Hirst e Jeff Koons. Warhol incarnava pubblicamente l\’eccentrico svampito, ma era una personalità lucidissima e priva di scrupoli, capace di riscattarsi da origini misere. Per realizzare il suo \”american dream\” gli mancava però il fattore che lo rendesse accettabile per la borghesia benpensante da cui voleva essere accettato e finanziato. Questo fattore furono proprio le sue superstar: ragazze bellissime, fragili e ribelli, in fuga da famiglie oppressive e violente che volevano per loro solo un futuro da brave mogli. Con tutte adottava la stessa tattica manipolatoria: le invitava a far parte della sua Factory, proponeva loro di far parte dei suoi film, le lasciava libere di ogni eccesso (droghe in primis). Quando si stancava di loro, di solito dopo un anno, si limitava a ignorarle, lasciando che una nuova ragazza prendesse il posto di quella precedente. Molte di loro non sono sopravvissute a questa strumentalizzazione: la storia di Edie è la più emblematica; ma non è l\’unica. Potremmo dire che Evelyn McHale, con la sua scelta così radicale, ebbe la lucidità di vedere che per le donne come individui non c\’era posto nella società americana. E vedendo oggi l\’inasprimento della legislazione antiabortista (qui un bellissimo TED) non possiamo che prendere atto che la guerra di genere, garantita da un sistema saldamente maschilista, è ancora in pieno fermento.
La voce narrante è quella dell\’artista Isabelle Collin Dufresne, aka Ultra Violet, che criticherà certe dinamiche della Factory. Perché hai scelto proprio il suo punto di vista?
La scelta di Ultra Violet è presto motivata: è stata tra le più longeve sopravvissute della Factory (è morta di cancro nel 2014). Inoltre, a differenza di molte altre warholettes, era di origine europea, aveva studiato in ottimi collegi, guardava ai meccanismi del successo americano con lucidità e consapevolezza. Quando arriva alla Factory è già l\’amante ufficiale di Dalì a New York, vive con lui nella mitica suite al St. Regis Hotel, impara da lui come usare i media per ottenere attenzione: ad esempio, quando ci sono dei reporter, si mette sempre alla sinistra di Andy Warhol, in modo che il suo nome compaia per primo nelle didascalie. In più di un\’occasione, leggendo le sue memorie e i suoi scritti, si ha l\’impressione che avesse ambizioni alte al suo arrivo a New York: fare la curatrice (un ruolo che non esisteva ancora), la gallerista o comunque la commerciante d\’arte; ma capiva bene che per le donne non era possibile avere una carriera se non stando molti passi indietro rispetto a un uomo potente. Ultra Violet ha la capacità – e questo è molto importante anche per il mio romanzo – di guardare agli anni \’60, alla controcultura, alla trasformazione finanziaria dell\’arte contemporanea cogliendo le analogie con il nostro tempo. Il \’68 ci appartiene più di quanto non vogliamo ammettere: la fine della guerra fredda, la globalizzazione, il compimento dei due modelli economici (del comunismo di stato e del capitalismo liberale) e il trionfo dell\’individualismo in occidente, ci ha tenuto per mezzo secolo in una bolla da cui ci risvegliamo con fronti di guerra imperialisti, crisi climatiche irreversibili, terrorismo domestico incontrollabile, nuovi fascismi radicali, oppressione delle donne, guerra ai migranti e, in tutto questo, una generazione di giovanissimi che urla e pretende alternative per il futuro costantemente derisa e banalizzata. Questo romanzo è per me anche un\’occasione per confrontarmi con il pensiero radicale degli anni \’60 incarnato da Valerie Solanas. Pensiamo a Greta Thunberg e ai ragazzi di Fff: ciò che affermano è destabilizzante e difficile da accogliere, spesso banalizzato o affossato dalle teorie del complotto e della manipolazione. Eppure, dicono cose vere e necessarie. Allo stesso modo, è ancora oggi difficile leggere i testi femministi radicali anni \’60, come Scum di Valerie Solanas, Sputiamo su Hegel di Carla Lonzi o altri testi di Rivolta Femminista. Eppure, le dinamiche che questi testi descrivono sono oggi compiute, nefaste e oppressive. L\’hanno previsto con decenni di anticipo e non sono state ascoltate dallǝ loro contemporaneǝ: direi che ripartire da lì non può che aiutarci a guardare con lucidità al nostro tempo.
Brescia, 2 giugno 2022