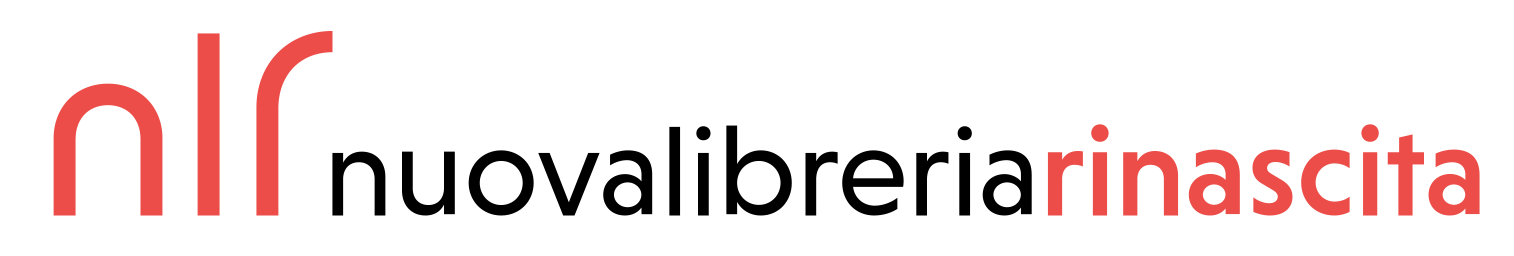Si è quel che si è fatto di ciò che la famiglia aveva fatto di noi Giorgio Fontana, Prima di noi, Sellerio 2020 (pp.891, euro 22)


La “famiglia singolare” è “la mediazione fra l’universalità e l’individuo”. La famiglia singolare, la mia famiglia, che non si esaurisce nei componenti che tuttora la compongono ma comprende le generazioni che hanno preceduto l’attuale; l’universalità: tutti gli altri che alla mia famiglia non appartengono, la società, ma anche il divenire della società, la sua storia. Le parole di Sartre, sulle quali il filosofo ha fondato – nelle sue Questioni di metodo – la ricerca confluita nella monumentale opera su Flaubert (L’idiota della famiglia, Il Saggiatore 2019) possono fornire la cornice entro la quale collocare il grande romanzo di Giorgio Fontana. Perché c’è l’Italia del Novecento, e della prima decade del nuovo millennio, in Prima di noi, ed è sicuramente, questa, una pista di lettura dell’opera, feconda, ma non unica, a meno che la si complichi di quella “mediazione” fra il singolare e l’universale, il particolare e il generale, e allora a trasparire come filo essenziale, che tiene insieme la storia, è il confronto fra le figure che via via prendono la scena e quelle che a lungo vi compaiono e vi conservano comunque un posto anche quando di scena sono uscite.
Continuità sotterranee e rotture eclatanti costellano il divenire della famiglia Sartori, dalla prima guerra mondiale ad oggi, nella forma di somiglianze di carattere, di affinità di comportamento e dì comunanza di aspirazioni, ma anche di drastiche ridefinizioni di questi elementi esposti all’influenza irresistibile dei tempi, all’evoluzione dei costumi, all’irrompere di mentalità nuove.
Torniamo a Sartre: “Il dato che superiamo ad ogni istante, per il semplice fatto di viverlo, non si riduce alle condizioni materiali della nostra esistenza, ma in esso va compresa la nostra stessa infanzia. Questa, che fu insieme un’apprensione oscura della nostra classe, del nostro condizionamento sociale attraverso il gruppo familiare, e un superamento cieco, uno sforzo maldestro per sradicarcene, finisce per iscriversi in noi sotto forma di carattere”.
Lo stampo che la famiglia imprime sui diversi personaggi è subito messo in questione dagli stessi: reinterpretato, fatto proprio, o ancora più spesso combattuto nel proprio intimo, giocato anche aggressivamente nelle relazioni familiari, contestato sulla base della propria esperienza pubblica. Maurizio è ormai altro, è fatto di una pasta diversa rispetto al padre, intriso della pazienza cupa dei contadini; i suoi figli sono a loro volta diversi da lui ma anche, si badi, diversi fra loro, perché i singoli processi di individuazione, di distacco dalle figure genitoriali, da quella paterna in ispecie, divergono: se Gabriele, cattolico, coltiva, e coltiverà per tutta la vita, le proprie aspirazioni letterarie, suo fratello Renzo, comunista, è nella fabbrica e nelle lotte sindacali che cercherà la sua verità, nella propria rabbiosa tenacia rivelando un tratto profondo di continuità con il padre. Così come la madre, nella sua ferma dirittura, nel suo quieto e coraggioso bastare a se stessa, sembra non aver perso radici antiche, che la riporteranno alla campagna che la famiglia aveva lasciato. E questa dialettica fra continuità e discontinuità, somiglianza e differenza rispetto sia a chi li ha preceduti sia ai coetanei, connoterà i figli di Gabriele così come quelli di Renzo, ormai calati nei “tempi miseri” che ai giovani gli ultimi decenni hanno offerto, minando ogni sentimento di appartenenza, non esclusa quella familiare: “Un cognome non vuol dire nulla”, dichiara Dario, “l’ultimo della stirpe, l’ultimo dei Sartori”: “I Sartori non esistono”, giunge a dire.
Non è tuttavia su questa constatazione, che sembra voler destituire di senso la lunga storia che abbiamo letto, che il romanzo si chiude, ma sul gesto di Letizia che si reca alla tomba del nonno Maurizio da cui tutto è partito. Maurizio, disertore nella Grande guerra, traditore della fiducia della ragazza che gli aveva creduto e dalla quale solo perché costretto era tornato, eppure a lei legato poi per una vita: Letizia “mise una mano sulla lapide e la sentì calda e ruvida. Una sorta di frenesia la colmò. Ora non c’erano più segreti né condanne, non esisteva ragione di vergognarsi o avere paura. Il cognome su quella pietra era pronto a sbiadire (…). Pietà dunque” per ciascuno dei Sartori, e soprattutto “per un ragazzo e una ragazza che si amano in un bosco, mentre intorno la guerra incendia la terra e loro ancora non sanno che lei verrà abbandonata – e ancora non sanno che lui ritornerà”.
Quel ragazzo e quella ragazza che sono stati i bisnonni dell’autore: “cos’ho voluto raccontare con queste quasi novecento pagine? – si è chiesto Fontana, raccontando il suo libro sul blog Letteratitudine. Forse innanzitutto un’inquietudine di fondo che anima i Sartori, diciamo una difficoltà radicale di stare al mondo: ognuno reagisce alla diserzione del capostipite inseguendo un sogno preciso che comunque non porta quiete – la rivoluzione, la religione, la poesia, la conoscenza, l’arte… Tutto è un modo per combattere la stortura ricevuta in eredità: ma tutto resterebbe inerte se ad esso non si aggiungesse una forma di pietas, una luce compassionevole, forse persino una preghiera rivolta al passato – alle vite inventate sepolte laggiù, negli abissi del tempo, prima di noi, e che irradiano il loro mistero”.
Brescia, 22 maggio 2020
Carlo Simoni
www.secondorizzonte.it