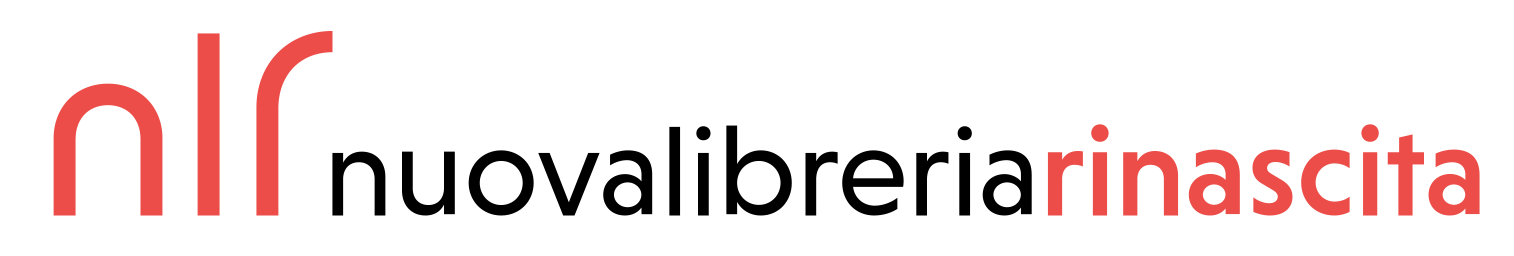Amiamo le nostre ossessioni Nadia Terranova, Addio Fantasmi, Einaudi 2018 (pp. 202, euro 17)
A che punto si è nella vita: forse è questo che dei loro protagonisti vorremmo i romanzi ci dicessero, e il racconto fosse lo spazio necessario per dirci delle ragioni e dei percorsi che li han portati lì.
Leggere romanzi è anche questo: confrontarsi con le storie di altri per ricavare spunti utili a far luce sulla propria, a farsi un’idea del punto cui ciascuno di noi è arrivato.
La vita di Ida è di quelle segnate da un prima e un dopo. Lei è nel dopo, ma non sa dimenticare il prima né tanto meno la linea che ha separato le due parti in cui la sua esistenza si è divisa. Ci sarà uno stacco ulteriore, una seconda cesura capace di restituirle una vita sua? Il titolo ce lo fa pensare, l’inizio no: la madre l’ha chiamata a Messina perché ha deciso di sistemare la casa in cui la famiglia abitava, in cui lei ha continuato ad abitare; in cui ha abitato anche il marito, il padre di Ida –fino al giorno in cui, senza preavviso, se n’è andato, è scomparso, annientato dalla depressione – e anche la figlia ha abitato, prima di trasferirsi a Roma, trovare un lavoro (scrive “finte storie vere” per la radio) e sposarsi, con un uomo gentile, con il quale però il desiderio si è esaurito. E il desiderio, quando si è incrinato, non si può “rattoppare”, neanche se si è ancora giovani, poco più che trentenni, e quel che resta sono allora la tenerezza, la comprensione, la solidarietà. Perché i matrimoni, tutti i matrimoni si arenano “imprigionati nella pretesa di avere accanto un’unica persona a cui abbiamo chiesto di farci da amante, compagno, familiare, amico, per poi assistere devastati all’inevitabile franare di una di queste definizioni o di tutte insieme.” Sono parecchie le pagine riservate al tema del rapporto fra uomini e donne, ma non è, questo, l’unico fulcro attorno al quale la narrazione si addensa: la madre ha chiamato la figlia per svuotarla, quella casa, non solo per sistemarla in vista di una possibile vendita. E qui emerge il discorso sugli oggetti, e sul loro essere appigli essenziali, veicoli imprescindibili della memoria: “Non voleva che un giorno potessi rinfacciarle di aver dato via i miei oggetti, bisognava che tornassi per scegliere cosa lasciar andare. Pensai che era facile, perché, a parte una scatola di ferro rosso custodita in fondo a un cassetto, non tenevo a niente.” Una scatola di ferro rosso: “dal momento in cui un oggetto compare in una narrazione, si carica d’una forza speciale”, notava Calvino, ed è questo il caso, come scopriremo nelle ultime pagine. Ma prima di arrivarci occorre attraversarne altre, pervase da un dire teso, accorato, incerto della propria necessità eppure costretto da un bisogno di ricostruire, capire, dissezionare i sentimenti, evocare fino allo stremo quel passato che non sa passare, quel lutto non elaborato dalla madre e tanto meno dalla figlia, e tuttavia marcando passi avanti, sempre precari ma capaci di fissarsi in frasi, in immagini che sostanziano la vicenda, la rendono unica, ne mettono in luce aspetti che vanno oltre di essa e ci raggiungono. A partire, appunto, dai passi dedicati alle cose che ci seguono nella vita, che conserviamo e finiscono per assumere la fisionomia di “speranze inutilizzate”. Perché “la vita non si fa con i residui”, e gli oggetti, anche i più cari, i più evocativi, “non sono affidabili”, e “i ricordi non esistono, esistono solo le ossessioni”. E ossessivo è il dolore della perdita del padre: “Hai permesso al tuo dolore di divorarti – dice a Ida l’unica amica rimasta nella città natale – e la tua ferita è diventata più grande di te. Vivi come una schiava, sei la schiava di quello che ti è successo”. E lo ammette la stessa protagonista: “Amiamo le nostre ossessioni, e non si ama ciò che ci rende felici”.
“Una diade ossessiva” è anche quella formata da madre e figlia: “sbranarci era un forma d’intimità”, riconosce Ida, che ha capito “cos’è davvero una madre: qualcosa da cui non esiste riparo. Dicono che una madre dà tutto e non chiede niente; nessuno dice invece che chiede tutto e dà ciò che non chiediamo di avere.”
Scrivere allora. Quelle storie per la radio: “io riuscivo a tollerare il dolore solo scrivendone, e trasformandolo in invenzione potevo trovare quella pace che nella quotidianità mi mancava”; “i fatti scorrono accanto a noi mentre ci illudiamo, un giorno, di dominarli. Ecco perché mi rifugiavo nelle mie finte storie vere: su di loro io esercitavo una signoria assoluta. Di quello che scrivevo ero sovrana. (…) Scrivendo, mi illudevo di essere autarchica.”
Non dalla scrittura però ma da un oggetto, anzi dai due oggetti riposti ventitre anni prima in quella scatola rossa, verrà la liberazione: dalla pipa appartenuta al padre e dalla sua voce, registrata in un’audiocassetta. Perché sono l’odore e la voce, “le due tracce più volatili”, a riportarci la vicinanza di chi è assente. Una vicinanza che può tuttavia risolversi nella distanza necessaria per vivere, finalmente.
Leggere romanzi è anche questo: confrontarsi con le storie di altri per ricavare spunti utili a far luce sulla propria, a farsi un’idea del punto cui ciascuno di noi è arrivato.
La vita di Ida è di quelle segnate da un prima e un dopo. Lei è nel dopo, ma non sa dimenticare il prima né tanto meno la linea che ha separato le due parti in cui la sua esistenza si è divisa. Ci sarà uno stacco ulteriore, una seconda cesura capace di restituirle una vita sua? Il titolo ce lo fa pensare, l’inizio no: la madre l’ha chiamata a Messina perché ha deciso di sistemare la casa in cui la famiglia abitava, in cui lei ha continuato ad abitare; in cui ha abitato anche il marito, il padre di Ida –fino al giorno in cui, senza preavviso, se n’è andato, è scomparso, annientato dalla depressione – e anche la figlia ha abitato, prima di trasferirsi a Roma, trovare un lavoro (scrive “finte storie vere” per la radio) e sposarsi, con un uomo gentile, con il quale però il desiderio si è esaurito. E il desiderio, quando si è incrinato, non si può “rattoppare”, neanche se si è ancora giovani, poco più che trentenni, e quel che resta sono allora la tenerezza, la comprensione, la solidarietà. Perché i matrimoni, tutti i matrimoni si arenano “imprigionati nella pretesa di avere accanto un’unica persona a cui abbiamo chiesto di farci da amante, compagno, familiare, amico, per poi assistere devastati all’inevitabile franare di una di queste definizioni o di tutte insieme.” Sono parecchie le pagine riservate al tema del rapporto fra uomini e donne, ma non è, questo, l’unico fulcro attorno al quale la narrazione si addensa: la madre ha chiamato la figlia per svuotarla, quella casa, non solo per sistemarla in vista di una possibile vendita. E qui emerge il discorso sugli oggetti, e sul loro essere appigli essenziali, veicoli imprescindibili della memoria: “Non voleva che un giorno potessi rinfacciarle di aver dato via i miei oggetti, bisognava che tornassi per scegliere cosa lasciar andare. Pensai che era facile, perché, a parte una scatola di ferro rosso custodita in fondo a un cassetto, non tenevo a niente.” Una scatola di ferro rosso: “dal momento in cui un oggetto compare in una narrazione, si carica d’una forza speciale”, notava Calvino, ed è questo il caso, come scopriremo nelle ultime pagine. Ma prima di arrivarci occorre attraversarne altre, pervase da un dire teso, accorato, incerto della propria necessità eppure costretto da un bisogno di ricostruire, capire, dissezionare i sentimenti, evocare fino allo stremo quel passato che non sa passare, quel lutto non elaborato dalla madre e tanto meno dalla figlia, e tuttavia marcando passi avanti, sempre precari ma capaci di fissarsi in frasi, in immagini che sostanziano la vicenda, la rendono unica, ne mettono in luce aspetti che vanno oltre di essa e ci raggiungono. A partire, appunto, dai passi dedicati alle cose che ci seguono nella vita, che conserviamo e finiscono per assumere la fisionomia di “speranze inutilizzate”. Perché “la vita non si fa con i residui”, e gli oggetti, anche i più cari, i più evocativi, “non sono affidabili”, e “i ricordi non esistono, esistono solo le ossessioni”. E ossessivo è il dolore della perdita del padre: “Hai permesso al tuo dolore di divorarti – dice a Ida l’unica amica rimasta nella città natale – e la tua ferita è diventata più grande di te. Vivi come una schiava, sei la schiava di quello che ti è successo”. E lo ammette la stessa protagonista: “Amiamo le nostre ossessioni, e non si ama ciò che ci rende felici”.
“Una diade ossessiva” è anche quella formata da madre e figlia: “sbranarci era un forma d’intimità”, riconosce Ida, che ha capito “cos’è davvero una madre: qualcosa da cui non esiste riparo. Dicono che una madre dà tutto e non chiede niente; nessuno dice invece che chiede tutto e dà ciò che non chiediamo di avere.”
Scrivere allora. Quelle storie per la radio: “io riuscivo a tollerare il dolore solo scrivendone, e trasformandolo in invenzione potevo trovare quella pace che nella quotidianità mi mancava”; “i fatti scorrono accanto a noi mentre ci illudiamo, un giorno, di dominarli. Ecco perché mi rifugiavo nelle mie finte storie vere: su di loro io esercitavo una signoria assoluta. Di quello che scrivevo ero sovrana. (…) Scrivendo, mi illudevo di essere autarchica.”
Non dalla scrittura però ma da un oggetto, anzi dai due oggetti riposti ventitre anni prima in quella scatola rossa, verrà la liberazione: dalla pipa appartenuta al padre e dalla sua voce, registrata in un’audiocassetta. Perché sono l’odore e la voce, “le due tracce più volatili”, a riportarci la vicinanza di chi è assente. Una vicinanza che può tuttavia risolversi nella distanza necessaria per vivere, finalmente.